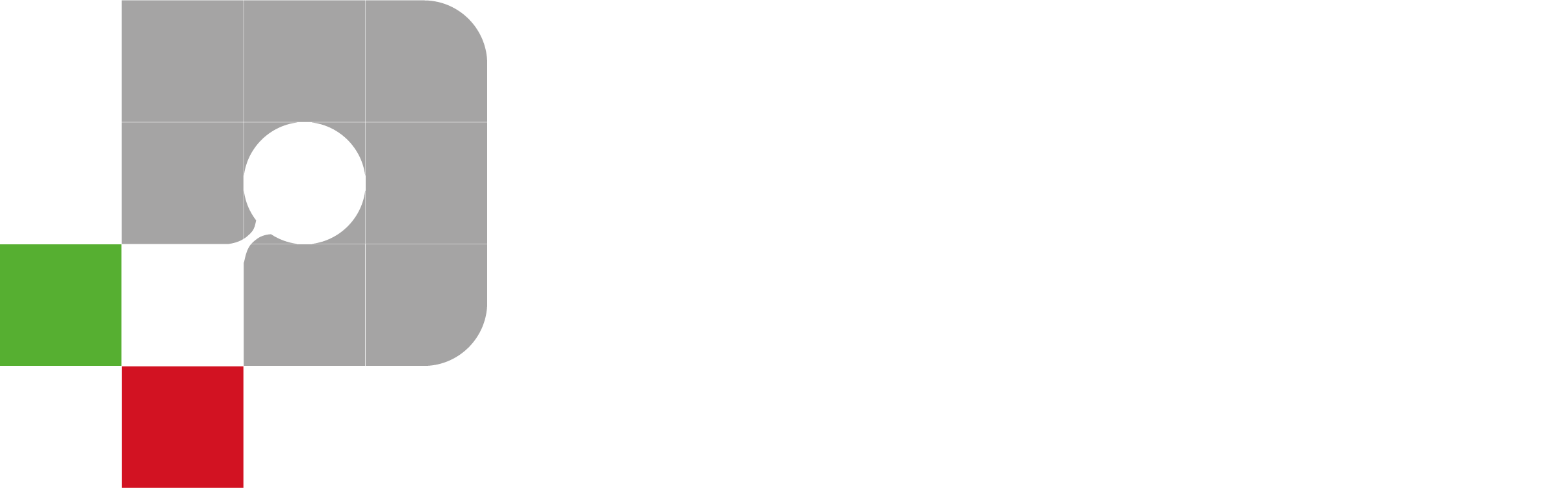È chiara la ratio sottesa all’introduzione nel nostro ordinamento di ipotesi in cui il ricorso alla mediazione sia obbligatorio, ovvero quale condizione di procedibilità della (successiva ed eventuale) domanda giudiziale. La disposizione di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 – il quale prevede le ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale – è stata costruita senz’altro in funzione deflattiva e, per tale ragione, deve essere interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale (Cfr. Cass., Sez. III civ., sentenza n. 24629 del 7 ottobre 2015).
Anche l’obiettivo posto dal legislatore europeo è stato quello di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie, promuovendo la composizione amichevole delle medesime ed incoraggiando il ricorso alla mediazione, anche al fine di «garantire un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario» (art. 1, § 1, Direttiva 2008/52/CE).
Dunque, in tale prospettiva, la mediazione obbligatoria mira (o, meglio dire, mirerebbe) a rendere il processo l’extrema ratio dell’ordinamento giuridico.
Tuttavia, nella pratica, siamo ben lontani dal raggiungere questa auspicata proporzione per cui il giudizio sarebbe il mezzo sussidiario laddove in sede di (previa) mediazione non si sia raggiunta una definizione amichevole della vicenda. Invero, a fronte della regolare attivazione di una procedura di mediazione, spesso non segue un’adeguata collaborazione di controparte che, pur ritualmente convocata – per animo litigioso o per altra strategia difensiva – decide di non partecipare, spesso senza addurre un giustificato motivo. Ebbene, siffatta condotta non sarà più attuabile o, quantomeno, non senza conseguenze.
Difatti, come da condivisibile e recentissima giurisprudenza, “l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso (Cfr. Trib. Roma, Sez. XIII civ., sent. 23.02.2017), in quanto idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale –evitabile – in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (Cfr. Trib. Palermo, Sez. I civ., sent. 29.07.2015). Alla luce di quanto precede, si ritiene che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione del Sig. (…) al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto degli art. 8 co. IV bis del D.Lgs. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorra a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della sua resistenza ad oltranza, e legittimi l’interesse dell’attore ad ottenere quanto richiesto in atto di citazione” (Cfr. Trib. Termini Imerese, sent. n. 412 del 07.04.2023).
Dunque, la mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione deve pacificamente considerarsi una condotta dolosa, da cui il Giudice adito sarà in grado di presumere un riconoscimento della fondatezza della tesi avversaria. In altri termini, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce argomento di prova in favore della parte contrapposta – che ha avviato la procedura di mediazione – e legittima la condanna al pagamento del contributo unificato. È preciso il Tribunale di Roma nel sancire che: “il mancato svolgimento della mediazione demandata non comporterà l’improcedibilità della domanda, bensì, ove il diniego della controparte non risulti giustificabile, l’applicazione a carico di quest’ultima dell’art. 8 del D. lgs n. 28 del 2010 oltre, ricorrendone i presupposti, dell’art. 96, comma 3, c.p.c.” (Cfr. Trib. Roma, Sez. XIII civ., sent. 23.02.2017).
Orientamento giurisprudenziale, quest’ultimo, recente e pienamente condivisibile al fine di incentivare – in maniera più incisiva – un serio ricorso a tale strumento di risoluzione alternativa delle controversie, nell’ottica di un’auspicata deflazione dei giudizi civili.