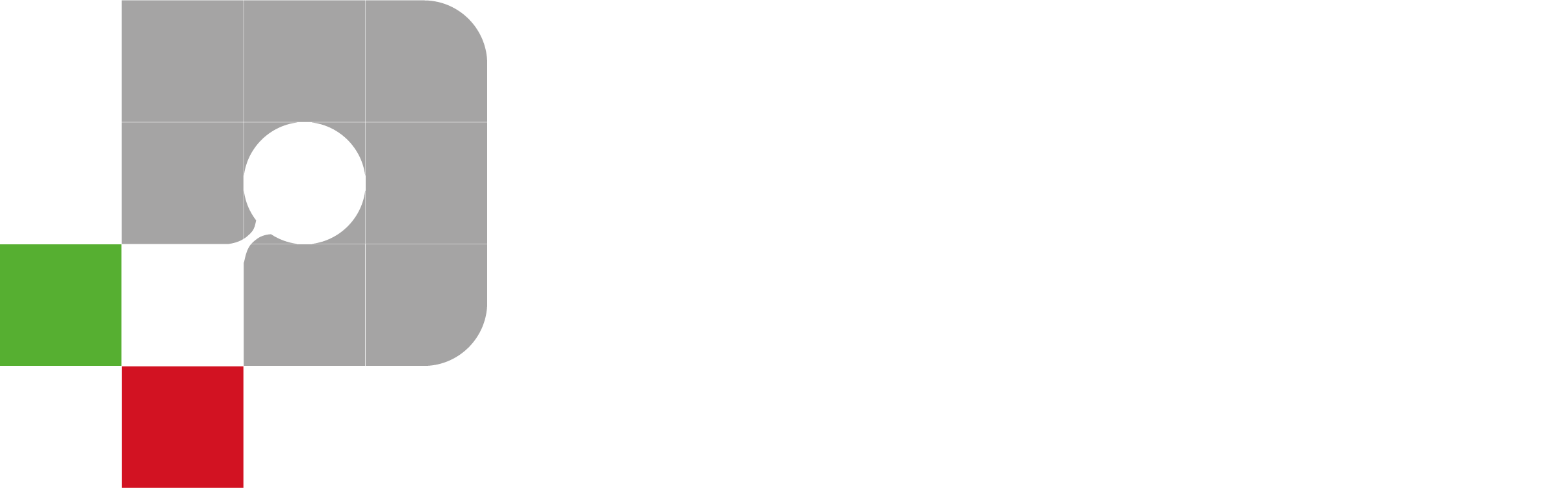È innegabile che la libertà di espressione, di stampa e/o di cronaca e, infine, di critica siano tra i pilastri fondamentali di una società democratica. Le medesime godono difatti di un’ampia protezione, ma certamente una siffatta tutela non può essere incondizionata od illimitata.
Uno dei limiti più attuali a siffatte libertà è imposto dalla necessità di perseguire la (emergente) fattispecie dei cosiddetti “hate speeches” o, in italiano, “discorsi d’odio”. A tal proposito è intervenuto il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il quale ha definito gli “hate speeches” come “le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o più in generale l’intolleranza, ma anche i nazionalismi e gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, gli epiteti, i pregiudizi, gli stereotipi e le ingiurie che stigmatizzano e insultano”.
Ciò premesso, ci si chiede se esistano – e quali siano – le forme di tutela azionabili a fronte di una condotta di tal tipo, nonché le iniziative assunte dal legislatore – europeo o nazionale – in una “Società della virale condivisione online” come quella attuale, in cui:
– sui profili social – soprattutto di personaggi pubblici – proliferano i cosiddetti “haters”;
– giornali e riviste online utilizzano titoli, frasi od epiteti spesso “accattivanti” alla ricerca del consenso popolare.
Trattasi di una questione – questa dell’incitamento all’odio – che ha interessato sin da subito le Istituzioni europee, il cui approccio si è spostato brevemente dall’uso della c.d. hard law a quello della c.d. soft law, verso l’uso di forme di co-regolamentazione. Il tutto ha condotto, in data 30 maggio 2016, all’adozione da parte della Commissione di un Codice di condotta sulla lotta all’odio illegale online – poi firmato dai maggiori attori del mercato telematico quali Facebook, Google, Microsoft e Twitter, cui si sono aggiunti nel 2018 anche Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion e jeuxvideo.com.
Precisamente, il succitato Codice di Condotta richiederebbe alle aziende informatiche firmatarie di adattare delle procedure interne al fine di garantire una rapida ed incisiva risposta in caso di discorsi d’odio veicolati attraverso le rispettive piattaforme online. In particolare, il codice richiederebbe che le società “valutino la maggior parte delle notifiche valide per la rimozione delle espressioni di odio illegale in meno di 24 ore e rimuovano o disabilitino l’accesso a tali contenuti, se necessario”. Infine, le aziende firmatarie dovrebbero altresì predisporre un sistema di notifica di rimozione che consenta loro di rivedere le richieste di rimozione anche “alla luce delle loro regole e delle linee guida comunitarie e, se necessario, delle leggi nazionali che recepiscono la decisione quadro 2008/913/GAI”.
Ciò che emerge da un primo esame del Codice di condotta di cui sopra, è che l’approccio adottato dalla Commissione europea sia prevalentemente incentrato sulla tempestiva rimozione del presunto “discorso d’odio”, piuttosto che sulle garanzie procedurali che un tale meccanismo dovrebbe adottare al fine di non limitare irragionevolmente ed arbitrariamente la libertà di espressione degli utenti.
Se, invece, si esamina l’ordinamento nazionale, addirittura non esiste neppure una specifica definizione di “discorso d’odio”: l’operatore del diritto deve pertanto agire in via interpretativa. Ed allora, gli artt. 2 e 3 della Costituzione garantiscono tutela contro e dalle discriminazioni. Ancora, diverse norme criminalizzano condotte assimilabili al concetto di “hate speech”: si consideri, ad esempio, la categoria dei reati d’opinione con conseguente punibilità della manifestazione del pensiero che offende i beni più svariati, quali l’onore, la reputazione o la riservatezza. Due sono le principali disposizioni penali: l’articolo 604-bis del codice penale – il quale punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa – e l’articolo 604-ter del codice penale – il quale prevede un’aggravante laddove un reato sia determinato da finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale, religioso.
Quanto alla (seppur limitata) tutela civilistica, può citarsi il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, per cui possono essere considerate discriminazioni anche le molestie, ovvero “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di “razza” o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”. Ed allora, anche civilmente, una siffatta condotta verrebbe considerata l’equivalente di un comportamento molesto e quindi sanzionabile con ammenda pecuniaria, con la rettifica sui giornali o simile.
Tutto quanto premesso, può facilmente concludersi affermando che né l’intervento nazionale né quello a livello europeo possono ritenersi un sufficiente strumento di tutela contro un fenomeno – qual è “l’incitamento all’odio” – sempre più diffuso. Del resto, non deve dimenticarsi che i codici di condotta emanati dall’UE – come quello menzionato – debbono ricondursi nella categoria degli atti atipici e, quindi, diversi da quelli di cui all’art. 288 TFUE: per tale motivo – seppur la loro adozione possa avere rilievo – gli stessi non sono fonti di norme giuridiche obbligatorie e vincolanti.
Specialmente a livello nazionale – anche nella recente relazione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 2022 – è stata sollevata la necessità di una chiara definizione della fattispecie in questione, dell’adozione di regolamenti chiari e di misure definite al fine di “distinguere dove finisce il diritto alla critica e la libertà di manifestazione del pensiero e dove inizia l’odio insopportabile e illegale”.
Ciò che lo scrivente si auspica è dunque un serio, mirato e puntuale intervento da parte del legislatore italiano: è chiaro che la fattispecie in esame non possa sottovalutarsi e che sia altresì dirimente interrogarsi, con serietà, sulle ricadute che condotte del tipo di cui si discute – riconducibili nella definizione sopranazionale di “hate speeches” – possano avere nelle menti più fragili di chi le subisce, anche alla luce dei sempre più frequenti, e spiacevoli, fatti di cronaca di similare connotazione.